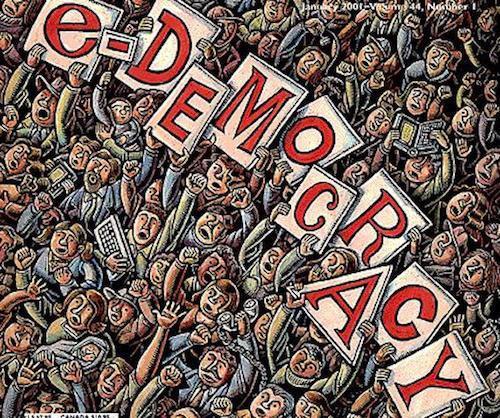
Prima di chiedersi se la democrazia sia esportabile o meno, cosa si intende per democrazia?
Per i politologi Giovanni Sartori e Robert Dahl, la democrazia è tale solamente se contempla la convivenza di due importanti componenti. La prima componente è quella che limita il potere, la seconda è quella che consente ai cittadini di beneficiare del potere. La prima fa riferimento al concetto esteso di “liberalità” e si sostanzia nella difesa di diritti che appartengono ad ogni singolo individuo della società. Attraverso lo stato di diritto, e la sua infrastruttura giuridico-istituzionale, quei diritti (“alla vita, alla proprietà e alla ricerca della felicità”) sono tutelati dalla libera discrezionalità del potere. La seconda componente nasce invece dalle rivoluzioni democratiche e si sostanzia nella partecipazione dei cittadini all’esercizio del potere. Se la componente democratica si è progressivamente diffusa (almeno su carta) , in particolare nel secondo dopo-guerra, non si può dire lo stesso per la componente liberale. Dei 193 stati che fanno parte delle Nazioni Unite, più di 2/3 si dichiarano democratici perché eleggono i propri governanti, ma solamente in una minoranza di essi vige uno stato di diritto. Non sono sufficienti le elezioni per definire, ad esempio, la Federazione Russa o la Repubblica Islamica dell’Iran tra i Paesi democratici.
La prima delle tante difficoltà che pone certo un freno a questo “sogno americano” risiede proprio nella difficoltà di esportare l’intero pacchetto inscindibile nelle due componenti. Difficoltà, peraltro, che ha segnato la storia della stessa America; infatti le potenze nordiste risultate vincitrici dopo un decennio di Guerra Civile non riuscirono a esportare lo stato di diritto negli stati del Sud, usciti sconfitti, nei quali, pur tenendo regolari elezioni, sono stati esclusi milioni di afroamericani dal godimento dei diritti civili, politici e sociali, senza sostanziali opposizioni. E poi questo sogno americano, che ha incontrato le prime difficoltà già nel paese di origine, ha tentato l’esportazione. Forse gli Stati Uniti, ubriacati dalla loro stessa grandezza, capaci di esportare e importare qualsiasi cosa, non hanno fatto i conti con ragioni assai complesse che, nella storia, hanno poi decretato il definitivo fallimento di questo modello.
Esportare la democrazia è un sogno che gli americani hanno promesso per primi ai popoli europei, in particolare nel secondo dopoguerra.
L’idea che nei paesi liberati bisognava non tanto instaurare regimi amici, ma soprattutto democratici, fu molto più forte negli americani di quanto non lo fosse negli inglesi. Sindacati, organi di informazione, apparato giudiziario, sistema produttivo, ricevettero tutti un sostegno notevole dall’amministrazione americana.
Da quel momento, esportare la democrazia è così stato iscritto come un DNA nelle priorità della politica estera americana. Neppure il dichiarato sostegno a governi di matrice chiaramente dittatoriale, hanno tolto dalla mente dell’americano l’idea che il proprio paese non è solo il più libero del mondo, ma anche quello che più di ogni altro sia in grado di impegnarsi a liberare gli altri.
Con quali mezzi e con quale efficacia? I successi oggettivamente ottenuti all’ indomani della Seconda Guerra mondiale nell’esportazione della democrazia in Germania, Giappone e Italia non possono essere generalizzati, anzi, gli Stati Uniti hanno quasi sempre fallito il proprio obiettivo quando hanno pensato di esportare in altri stati la propria forma di governo.
Complessivamente, la mania americana di esportare la democrazia con le armi ha prodotto più insuccessi che trionfi. Da queste esperienze, sembra che si possano dedurre alcune lezioni.
Analisi del contesto interno: già Benedetto Croce riteneva che la libertà non potesse essere esportata come un prodotto o un’ideologia preconfezionata. Ogni nazione ha il suo percorso storico e le sue peculiarità culturali, che determinano come e quando la libertà può essere realizzata. Tentativi di imporre la libertà dall’esterno spesso falliscono perché non tengono conto di queste specificità storiche e culturali. Prima di tutto, bisogna valutare qual è il grado di consenso nei confronti del regime esistente. Purtroppo, non tutti i regimi autoritari sono ugualmente avversati dalla popolazione, e spesso godono anche di un ampio appoggio, che si è espresso con libere ed eque elezioni. Voler imporre militarmente la democrazia, letteralmente “il potere del popolo”, contro la volontà del popolo stesso è insensato già in partenza. Occorre anche che siano attive forze endemiche desiderose di instaurare un regime democratico e personalità capaci di condurlo. Sicuramente, è “facile” re-introdurre la democrazia, ma difficile introdurla: in paesi quali l’Italia e la Germania, l’esistenza di istituzioni democratiche, anteriori all’avvento delle dittature, costituiva già un modello e aveva consentito la sopravvivenza di partiti e gruppi clandestini sia all’interno che all’esterno del paese, che si assunsero il compito di traghettare i propri paesi dal vecchio al nuovo regime. In paesi che non hanno mai sperimentato la democrazia, la sua applicazione risulta pressochè impossibile.
Sempre per dirla con Croce, la libertà deve prima di tutto svilupparsi organicamente all’interno di una società attraverso il processo storico. Questo sviluppo è legato alla crescita della coscienza civile e politica del popolo, che non può essere accelerata artificialmente. V’è poi da chiedersi, in linea generale, al di là della realizzabilità del progetto e alle trattate speculazioni puramente teoriche , quanto sia eticamente corretto imporre questa forma di governo a popoli che non l’hanno mai conosciuta, in sfregio al principio di sovranità nazionale, secondo il quale ogni popolo ha il diritto di autodeterminarsi senza interferenze esterne, ritenendo che il cambiamento e il progresso verso la libertà debbano essere guidati internamente dai cittadini e non imposti dall’esterno. In questo caso si aprono due visioni che tendono a escludersi vicendevolmente: se un popolo è insoddisfatto del proprio regime politico ha la possibilità di ribellarsi. Nel momento in cui si rompe il rapporto tra governo e popolo, fino al punto da sfociare in aperto conflitto, si crea la possibilità dell’intervento anche per forze esterne, che non possono effettivamente essere accusate di aver minacciato la pace, perché il conflitto era già divampato. Quando gruppi diversi si contendono il potere, diventa lecito per gli stati democratici dare il proprio appoggio alla parte politica che rivendica l’introduzione di un sistema democratico (che comprende, dunque, anche la rinuncia al governo da parte degli insorti qualora dovessero non acquisire il consenso elettorale). Ma in assenza di un’esplicita ribellione che segnali l’intenzione del popolo di cambiare regime, l’intervento diventa eticamente sospetto. Infine, nel momento in cui si opta per l’uso della forza militare per promuovere la democrazia, viene impiegato un mezzo che contraddice il fine.
I mezzi violenti della guerra non coinvolgono esclusivamente i despoti, ma inevitabilmente finiscono per colpire anche i cittadini che si presume sarebbero beneficiati dal regime democratico. Si giunge così alla condizione perversa degna del paradosso narrato da George Orwell: si usa la guerra per promuovere la pace, si somministra violenza per ottenere democrazia. Sono riflessioni che riportano a più di 2000 anni fa, all’ablativo assoluto Cesare Consule e al suo concetto di Bellum Iustum, del quale il Romano non parlò mai esplicitamente ma che traspare fra le righe dei suoi commentarii del De bello gallico e De bello civili, nei quali viene fornita la descrizione di una guerra che arriva a civilizzare popolazioni rozze e violente, profondamente bisognose dell’esperienza romana.
Ma la verità dietro alla giustificazione civilizzatrice della guerra di Cesare è quello di una realtà durissima, e il paradosso morale che questa suscita è vivo anche oggi. Appresa dagli eventi storici la pratica impossibilità di esportare libertà e democrazia in paesi estranei a questi concetti, consapevoli dei paradossi generati da questa attività, volendo anche apprezzare in linea teorica il principio del portare la libertà dove non c’è, resta poi da verificare, sulla scorta delle riflessioni fatte sul De Bello cesariano, i reali intenti degli Stati che si fanno portatori di questo ideale. A oggi possiamo dire, con una certa sicurezza, che mai le operazioni militari volte a introdurre libertà siano riuscite a conseguire questo scopo, perché forse non era questo il reale obbiettivo, quanto piuttosto la necessità di arginare regimi in grado di minare l’autorità della potenza occidentale di turno o la necessità di questa di estendersi in ambito economico e geopolitico. La retorica della libertà è spesso utilizzata dalle potenze occidentali per giustificare interventi militari, quando dietro alla facciata si nascondono spesso interessi economici.
Promuovere l’autodeterminazione serve a mascherare vere e proprie operazioni di potere e controllo. Molti osservatori, studiosi e attivisti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla presunta ipocrisia e alla doppia morale nell’uso della retorica della libertà per giustificare interventi militari.
Secondo questa prospettiva, gli interventi militari sono spesso presentati al pubblico occidentale come missioni finalizzate alla tutela dei diritti umani o alla stabilità politica. Tuttavia, dietro queste affermazioni idealistiche, si sospettano motivazioni più pragmatiche, come il controllo delle risorse naturali, la sicurezza nazionale o la delimitazione della sfera d’influenza di altre nazioni.
Ci sono esempi storici e contemporanei in cui le potenze occidentali sono state accusate di utilizzare la retorica della libertà per giustificare interventi militari controversi o per perseguire i propri interessi strategici. Questi casi sollevano importanti questioni sulla trasparenza della politica estera e delle azioni militari.
È importante esaminare criticamente le motivazioni all’origine degli interventi militari, e pretendere un’analisi approfondita dei veri obiettivi di tali azioni. Questo tipo di discussione potrebbe contribuire a una maggiore consapevolezza pubblica e a una maggiore responsabilità da parte dei governi e delle istituzioni internazionali. Interessante è la visione dello storico Canfora, che attribuisce un ruolo particolarmente rilevante, nell’esame critico delle dinamiche internazionali e dunque militari, alla figura “dell’intellettuale” che, forte del suo nutrito bagaglio culturale, ha il compito di sfidare le narrazioni dominanti promosse dai governi o dalle élites politiche, specialmente quando si tratta di questioni come guerre, interventi militari o relazioni internazionali allo scopo di offrire una prospettiva critica in grado di promuovere la pace, la cooperazione e la giustizia globale.






