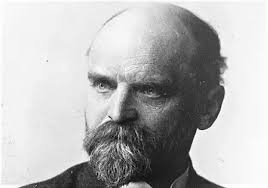
A Ferdinand Tönnies, fondatore della sociologia tedesca insieme con Werner Sombart e George Simmel, si deve la più completa definizione del “comunitarismo” come reazione alle strutture societarie del liberalismo borghese. E’ probabile, come è stato detto più volte, che Tönnies non sia mai riuscito a creare una scuola, tuttavia le sue teorie hanno alimentato il dibattito culturale in questo secolo fino ad influenzare i movimenti politici più vari che a diverso titolo si sono richiamati e si richiamano allo spirito comunitario.
Per quanto la produzione di Tönnies sia ragguardevole, il suo nome e la sua fama restano legati all’opera che racchiude tutto il suo pensiero: Gemeinschaft und Gesellschaft (Comunità e Società), la cui prima edizione è del 1887. E’ difficile, partendo da questo lavoro, incasellare ideologicamente il suo autore. Personalità complessa, Tönnies pur muovendo dalla scolastica marxiana non esitò ad emanciparsi da essa capovolgendo gli assunti di Marx, che erano di ordine economico, gettando con la nozione di Comunità le basi di una nuova interpretazione dei rapporti politici lontana da quella discendente dal materialismo dialettico e dall’utilitarismo liberale, cioè a dire «premessa della perfetta unità delle volontà umane come stato originario e naturale».
L’importanza dell’opera di Tönnies è racchiusa nell’originale riflessione sulle cosiddette “forme sociali e concrete” alla cui determinazione hanno lavorato nel Novecento i teorici dell’organicismo statuale e studiosi come Herman Schmalenbach e Talcott Parson.
Ferdinand Tönnies nacque il 26 luglio 1855 a Riep sulla costa occidentale dello Schleswig-Holstein dove avrebbe vissuto per buona parte della sua vita. Nel 1881 divenne assistente nell’università di Kiel e nel 1909 ottenne l’incarico di professore di Scienze sociali nello stesso ateneo, divenendo nel contempo presidente della Società tedesca di sociologia. Nel 1920 ottenne la cattedra di Sociologia sempre a Kiel, dove morì il 9 aprile 1936.
Fra le opere principali ricordiamo: Der Zarismus und seine Bundesgenossen (1914), Die Schuldefrage (1919), Kritik der Offentlichen Meinung (1922), Neue Beitrage zur Kriegschuldfrage (1922) e le biografie di Thomas Hobbes e di Karl Marx. L’opera più famosa, come si è detto,è Gemeinschaft und Gesellschaft alla quale Tönnies lavorò praticamente per tutta la vita, correggendo e modificando le sue ben otto edizioni. Tutti gli altri scritti del sociologo non sono altro che un ripensamento e una rielaborazione delle idee fondamentali esposte nel lavoro principale, circostanza questa che comprova la sostanziale “unicità” dell’opera di Tönnies.
Le “fonti” delle quali lo studioso si serve per costruire la sua teoria sono innumerevoli, ma è soprattutto alle intuizioni di Auguste Comte, di Herbert Spencer, di Albert Schäffle, di Adolf Wagner che attinge, senza trascurare gli studi di Henry Maine, autore di Ancient Law, Village communities in the East and West e Dissertation on Early Law and Custom di J.J. Bachofen, storico del diritto e autore celebrato di Das Mutterrecht; di Otto von Gierke soprattutto per le opere Das Deutsche Genossensch altrecht e Johannes Althusius und die Entwichlung der naturrechtlichen Staatsteorien; di Karl Marx per le riflessioni contenute in Zur Kritik der politiche Oekonomie.
Con la pubblicazione di Gemeinschaft und Gesellschaft, Tönnies, come ebbe a rilevare nel 1936 lo studioso tedesco Freirer, diede inizio ad una sociologia di tipo filosofico corrispondente ad una visione tipicamente tedesca, capovolgendo cioè l’ottica sociologica dell’epoca dominata dall’indirizzo francese.
Nell’ambito della cultura di Weimar, Tönnies trovò l’ambiente favorevole all’accoglimento benevolo delle proprie teorie soprattutto grazie all’entusiasmo con cui a esse guardavano i sostenitori della Jügendbewegung, il “Movimento dei giovani”, dalle cui file sarebbe uscita buona parte degli intellettuali di punta della rivoluzione conservatrice.
I giovani che animavano il “Movimento” ritrovarono nell’opera di Tönnies il fondamento scientifico delle loro intuizioni rivoluzionarie con le quali contestavano la società del tempo e un’esplicitazione teorica del loro entusiasmo per il “potere vitale dell’esistenza”, anche se Tönnies, come osservò A. Salomon nel saggio a lui dedicato in occasione della sua morte, aveva un temperamento estremamente razionalista e «nessuna cosa fù più estranea alla sua mente che l’indirizzo emozionale e l’irrazionalismo del movimento della gioventù».
Il nazionalsocialismo giudicò Tönnies “persona non grata”, ma nonostante l’ostilità delle gerarchie, nel 1936, l’anno della sua scomparsa, venne pubblicato un volume di scritti in suo onore. In realtà, gli ambienti conservatori tedeschi, guardati con sospetto dal regime, auspicavano un ritorno allo spirito della comunità in virtù dell’avversione che nutrivano verso le strutture societarie del liberalismo borghese e scorgevano nell’opera di Tönnies i fondamenti teorici che avrebbero dovuto presiedere alla costruzione della Volkgemeinschaft .
Come si configurano nel pensiero di Tönnies la Comunità e la Società?
La comunità organica di un gruppo umano vivente in comune, per il sociologo si basa «sulla perfetta unità delle volontà umane come stato originario o naturale, che si è conservato nonostante e attraverso la separazione empirica, atteggiandosi in forme molteplici a seconda della natura necessaria e data dei rapporti tra gli individui diversamente condizionati».
Ma c’è un elemento ancor pù particolare su cui si fonda la Comunità. Dice Tönnies: è la dignità. Un elemento che nessun sociologo prima di lui aveva “isolato” e considerato scientificamente. «Si può chiamare dignità o autorità» scrive Tönnies «una forza superiore che viene esercitata per il bene dell’inferiore o seccondo la sua volontà, e viene perciò affermata da questa. Se ne possono così distinguere tre specie: la dignità dell’età, la dignità della forza e la dignità della saggezza e dello spirito. Tutte e tre si trovano unite nella dignità che compete al padre, che sta al di sopra dei suoi in posizione di tutela, di assistenza, di guida. Il lato pericoloso di questa potestà genera nei più deboli il timore, e questo di per sé quasi soltanto negazione e rifiuto (a meno che ad esso non sia frammista l’ammirazione); ma il lato benefico di essa e la benevolenza inducono all’onore ed in quanto essa predomina, dall’associazione nasce il senso della reverenza. Così la tenerezza e la reverenza, o (in grandi più deboli) la benevolenza e il rispetto si contrappongono come le due determinazioni-limite – nel caso di una decisa differenza di potestà – del modo di sentire che è alla base della comunità».
Tönnies considera come esempi sui quali la comunità si fonda i rapporti più prossimi derivanti dalla discendenza e dal sesso, e quindi quelli più lontani espressi dalla parentela, dal vicinato, dall’amicizia dall’omogeneità dei mestieri e delle arti esercitate.
Tutti questi rapporti sono “legittimati” dal “consenso”, vale a dire dalla comprensione che si estrinseca come modo di sentire comune che costituisce la “volontà propria” della Comunità, ma anche la forza che tiene uniti gli uomini come membri di un tutto. Alla base delle forme di Comunità richiamate c’è sempre la stessa nozione di “eredità comune”: di sangue, cultura, religione, storia, etnia, etc.: ”eredità comune” che, al contrario di quanto sarebbe portati a credere, non appiattisce uniformandoli gli appartenenti, ma, al contrario, li differenzia essendo essi partecipi organicamente differenziati dei vari “corpi” che concorrono a formare la Comunità.
Discorso inverso per l’individuazione della società. Essa, osserva Tönnies, «muove dalla costruzione di una cerchia di uomini che, come nella comunità, vivono e abitano pacificamente uno accanto all’altro, ma che non sono già essenzialmente legati, bensì essenzialmente separati». Con questo Tönnies vuol dire che nella società non esiste alcun bene comune e ogni individuo vive dei propri beni escludendo gli altri, in continua tensione di fronte ai suoi simili. Ecco perché in tale forma di aggregazione umana i rapporti tra i singoli sono essenzialmente di scambio il cui suggello è il contratto «risultante di due volontà individuali divergenti che s’intersecano in un punto».
Le forme comunitaria e societaria rispecchiano anche (e soprattutto) le strutture funzionali-abitative che gli uomini si danno.
In un passo esemplare e scintillante della sua opera, Tönnies sottolinea: «Le forme esteriori della vita in comune quali sono date dalla volontà organica e dalla comunità, sono state distinte come casa, villaggio e città. Questi sono i tipi duraturi della vita reale e storica in generale. Anche nella società sviluppata, come nelle epoche primitive e medie, gli uomini coabitano secondo questi tipi. La città è la più elevata e perciò stesso la più complicata delle forme della vita comune in generale. Ha in comune con il villaggio una struttura locale in opposizione alla struttura familiare della casa. Ma la città e il villaggio conservano molti caratteri appartenuti alla famiglia: nel villaggio sono numerosi, nelle città in quantità media. Solo quando la città si evolve in grande città li perde quasi per intero; le persone individuali o anche le famiglie sono allora divise, e non sono radunate in un luogo comune, scelto come casa di abitazione, che in un modo fortuito. E così come la città persiste all’interno della grande città, così pure i modi di vivere della comunità persistono in generale, come i soli reali, all’interno della società, anche se vi si trovano atrofizzati e si estinguono a poco a poco. Le grandi città, come le nazioni e il mondo, non sono costituite in tutte le loro forme, che da persone libere, che, nel traffico, sono costantemente in contatto le une con le altre, fanno scambi tra di loro e cooperano, senza che la comunità e la volontà comunitaria possano esistere fra di loro se non in una maniera sporadica, o come residuo di stati primitivi che ne sono ancora i fondamenti.(…) La grande città è, semplicemente, il tipo della società».
Nella Gesellschaft, nella Società, dunque, l’anonimato diventa la regola, l’interesse personale la morale dominante, ogni manifestazione o atteggiamento umano rispondente ad uno sterile criterio di razionalità. Analizzando i due tipi di volontà che stanno alla base delle nozioni di Comunità e di Società, Tönnies individua una “volontà essenziale” e una “volontà arbitraria”. La prima è «l’equivalente psicologico del corpo umano, cioè il principio dell’unità della vita, in quanto questa viene concepita sotto quella stessa forma della realtà alla quale appartiene lo stesso pensiero». La seconda, invece «è una formazione del pensiero stesso, la quale possiede una vera e propria realtà soltanto in relazione al suo autore, il soggetto del pensiero, anche se essa può venir conosciuta o riconosciuta da altri». La Comunità, quindi, discende da «caldi impulsi del cuore», mentre la Società «procede dal freddo intelletto».
Inutile dire che Tönnies dimostra ampiamente di preferire la Comunità alla Società in quanto nella prima individua concretizzazione di un modello reale di vita organica, e nella seconda un ideale di vita meccanico. Esempi contrapposti – all’estremo limite – delle due sono il mondo contadino legato alla terra, con tutti i significati che essa racchiude, e quello del mondo mercantile che vive rinchiuso nel proprio egoismo utilitaristico.
Questi i capisaldi della teoria di Tönnies dalla quale hanno originato le moderne elaborazioni neo-comunitariste.
Pur concordando con l’affermazione di Pitrim Sorokin secondo il quale essa non è del tutto originale dal momento che spunti dello stesso genere sono riscontrabili in Platone, Aristotele, Heghel, von Gierke, non dobbiamo dimenticare che il merito dello studioso tedesco è stato soprattutto quello di aver collocato le nozioni di Comunità e di Società in un’esatta prospettiva storica che gli ha permesso di rispondere agli interrogativi di sempre della sociologia politica, vale a dire quelli concernenti le origini dell’uomo, la sua innata vocazione, il suo futuro.
A questo punto s’impone una domanda: è possibile ritornare alla Comunità, o quanto meno a ricrearne nelle condizioni attuali lo spirito, dopo le devastazioni operate dal razionalismo e dall’”ideale moderno”?
La conclusione che Tönnies adombra nella sua ultima ed incompiuta opera Geist der Neuezeit (Lo spirito dei tempi nuovi, 1935) è in senso positivo. La società, sostiene, sarà divorata dalla sua stessa crescita: un corpo troppo grande per un cervello troppo piccolo. La radicale inversione di tendenza sta soltanto, dunque, nella ripresa dei cosiddetti valori tradizionali. Per necessità o per volontà.
Non sappiamo se per l’una o per l’altra oggi stia riaffiorando un nuovo senso di comunità nazionale che la politica è ancora incapace di comprendere. Forse siamo ancora molto lontani dalle prospettive e dalle speranze di Ferdinad Tönnies, ma un fatto è indiscutibile: il sentimento dell’appartenenza non si lascia vilipendere a lungo; prima o poi ciò che fa la natura dell’uomo prepotentemente riemerge.






