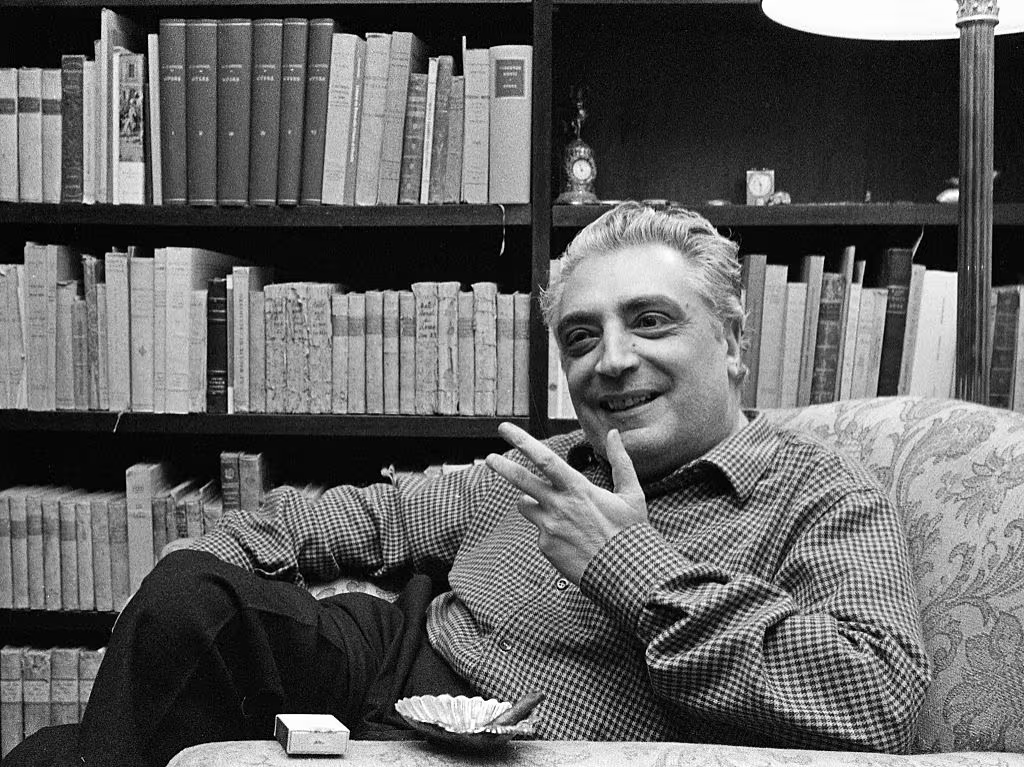Che ne è della (un tempo) celebrata e temutissima minoranza interna? Nei fasti della Prima repubblica, ogni partito ne contava almeno una. Solo il Pci aveva pudore a dichiararne l’esistenza in vita, forse per antico riflesso connesso al settarismo coltivato nella clandestinità. Tanto è vero che sul fronte opposto persino il Msi, pur rivendicando ascendenze autoritarie, non disdegnava la divisione in spifferi e correnti. E questo perché a quei tempi una leadership non era per sempre, ma rappresentava un assetto pro-tempore, quasi sempre frutto di uno scontro congressuale disputato per tesi contrapposte: i sostenitori di quella vincente tentavano di trasformarla in strategia politica mentre i fautori della tesi soccombenti s’industriavano a sabotarla in attesa di tempi migliori. Tra un’assise e l’altra, maggioranza e minoranza interna continuavano ad annusarsi, sfidarsi e a contaminarsi reciprocamente. Un prodigio alchemico racchiuso nella formula della cosiddetta “dialettica interna”, eufemismo che spesso serviva a celare pudicamente contrasti profondissimi e spaccature verticali. Nessuna meraviglia, dunque, se a dettare la linea politica contribuivano più le tribolazioni intestine che gli obiettivi esterni.
Anche qui nulla di nuovo e neanche di specificatamente italico visto che era stato Charles de Gaulle a bollare – con il disgusto tipico del generale per tutto ciò che non è militaria – la politica come «cucina dei partiti». Tutto normale, dunque. Come il fatto che nessuno potesse restare leader a dispetto dei suoi insuccessi. Precisazione, quest’ultima, oziosa solo in superficie se si considerano i tanti che ancora oggi dettano legge internamente ai propri partiti a dispetto dei loro clamorosi fiaschi, politici ed elettorali. Succede, appunto, perché la minoranza latita ovunque. Tranne che nel Pd, quantunque anche lì essa si dispieghi in forme ormai del tutto inedite rispetto al passato prediligendo sortite estemporanee, spesso disordinate e per lo più legate a rivendicazioni di carattere personalistico o, tutt’al più, di gruppo. Così fan tutti, insomma. E i risultati si vedono: il sondaggio di fine anno sugli orientamenti politici degli italiani effettuato dall’Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera stima in un roccioso 42,2 per cento (+ 3,2 rispetto alle elezioni politiche del settembre del ’22) la quota di cittadini astenuti/indecisi. Le ragioni della disaffezione sono tante, milioni di milioni, come le stelle della pubblicità del famoso salame, ma non v’è dubbio che fra esse meriti menzione anche l’assenza nei partiti di minoranze interne organizzate. Che poi significa accelerare la decomposizione democratica nei partiti e, conseguentemente, arrecare un grave vulnus all’art. 49 della Costituzione («Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale»).
Già, forse non è chiaro a tutti ma la nostra Carta Fondamentale tutela più il mezzo che il fine. Significa che un movimento, un partito (non uno fascista redivivo, la cui ricostituzione è espressamente vitata) può anche perseguire obiettivi anti-democratici (ad esempio, la dittatura del proletariato) purché con modalità democratica. Se tanto ci dà tanto, chiunque può capire che la «madre di tutte le riforme» non è tanto il premierato, quanto la necessità di restituire pregnanza (e legalità) all’art. 49 “costringendo” i partiti a rendere contendibili le proprie leadership e a concorrere anche al loro interno. Facile a dirsi, quasi impossibile a farsi dal momento che l’argomento va ad impattare frontalmente l’iceberg della legge elettorale. E persino un bambino capirebbe che fin tanto che vigerà l’attuale sistema di voto, ogni capo di partito si sentirà in una botte di ferro. Non gli sfugge, infatti, che chi dovesse dissentire dalle sue decisioni metterebbe a serio rischio la propria candidatura e quindi la propria nomina (non elezione!) a deputato o a senatore. E non è finita, perché il meccanismo di nomina – in uno con la coincidenza nella stessa persona di leadership e premiership – ribalta completamente il rapporto tra governo e Parlamento: è il primo a controllare e a condizionare il secondo e non viceversa, come sarebbe fisiologico in una qualsiasi democrazia. Basta e avanza per rendersi conto che il tema della minoranza interna non è argomento minore o tale da affidare alla magnanimità dei leader o alla sensibilità degli statuti. Al contrario, dovrebbe diventare un dato strutturale del contesto politico per dare così attuazione alla sollecitazione costituzionale dell’art. 49.È infatti prevedibile che partiti finalmente contendibili finiscano per rendersi più appetibili agli occhi dei cittadini anche sotto il profilo dell’impegno e della partecipazione, con possibile recupero della disaffezione popolare e, quindi, con possibile riduzione della percentuale di astensionismo che oggi fa del non-voto di gran lunga il primo partito degli italiani. E se sul piano più istituzionale il ritorno dei partiti alla democrazia potrà ricondurre la dialettica governo-Parlamento nel suo corretto alveo, sotto quello più afferente alla polemica politica significherebbe disarmare i solerti denigratori della Casta, tanto quelli annidati del loggione quanto i loro sobillatori mimetizzati in platea. Insomma, piaccia o meno, il futuro dei partiti passa anche dall’esistenza al loro interno di una minoranza organizzata. Non si tratta di rimpiazzare gli attuali reggimenti prussiani dove il capo decide per tutti con delle armate bracaleone in cui non comanda nessuno, bensì di restituire le forze politiche al loro ruolo di raccordo con la società civile e di strumento di selezione della classe dirigente. Purtroppo (o per fortuna), una democrazia senza partiti non è ancora alle viste mentre i partiti senza minoranze li stiamo già assaporando. E ci siamo accorti tutti che sono più insipidi di una minestra senza sale.