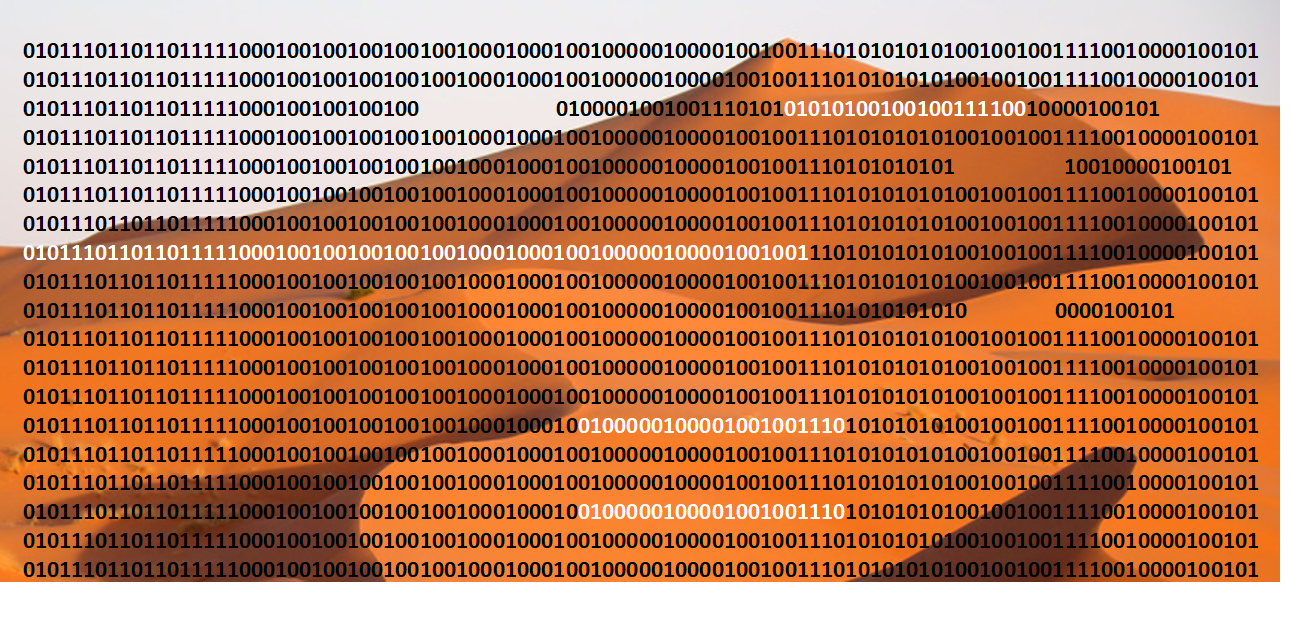
Se la nostra memoria individuale e collettiva improvvisamente svanisse? Se gli eventi che viviamo e cataloghiamo e preserviamo con gli strumenti tecnologici più sofisticati a nostra disposizione dovessero svanire perché le macchine a cui li abbiamo affidati s’inceppano, deperiscono, muoiono? Quante mail già adesso vengono distrutte e nessuno pensa che il racconto dell’umanità per buona parte si è sviluppato con i carteggi, le missive inviate mediante i più rudimentali strumenti, attraverso la tradizione orale che ha trasmesso musica, poesia, filosofia ed eventi storici o di nessuna apparente importanza come quelli appartenenti alla cultura materiale? E le intime narrazioni che danno un senso alla storia dell’amore, dei sentimenti, delle fedi in quale immondezzaio tecnologico finiranno perché i messaggini, gli emoticon, i filmini rubati e diffusi hanno per loro natura una effimera vita, come le foto postate sullo smartphone, sulla caricatura di un orologio che esibiamo ai polsi non per guardare l’ora, ma per essere sempre “connessi”, sui computer che vanno in tilt e non c’è tecnico che sappia resuscitarli? E poi tutto è ingombrante. Perfino il ricordo di un bacio, di un abbraccio; mentre davanti ad un pensiero ad un verso bisogna valutare, prima di fissarli sul tablet o sul cellulare, quanti gigabyte occupano per non inibirci l’invasione di altre ordinarie scene da consumare nell’attimo di un selfie.
La tecnologia distrugge se stessa. Dopo aver deprivato dell’anima chi ne fa un uso smodato (quasi tutti). Insomma, se tutto quanto abbiamo accumulato, dovesse evaporare, tramutarsi nel nulla, che cosa resterà della nostra umanità?
“Dietro di noi un deserto digitale, un altro Medioevo”. Queste parole sono state dette tempo fa da Vinton Cerf, uno dei padri di Internet, insieme con Bob Kahn, “mago” del Web, vice-presidente di Google dopo essere stato assunto dalla stessa azienda come Chief-Internet Evangelist. Le avesse dette chiunque altro, avrebbero avuto poca importanza, ma proferite da chi per mestiere deve “ossessionarci” con la digitalizzazione di ogni cosa, dal sesso alla raccolta differenziata, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. E siccome neppure alle brutte notizie siamo ormai più sensibili, facciamo finta di niente. Ma non si può restare stupiti che da quanto Cerf si è espresso in tal modo, e sono passati alcuni anni, non è stato avviato neppure uno straccio di discussione pubblica, perfino la comunità scientifica è rimasta muta.
Che il “deserto digitale”, dunque, cresca pure attorno a noi, che il Ventunesimo secolo diventi “un’epoca quasi inaccessibile alla storia”, come Cerf, allarmato e per nulla condizionato dal suo ruolo, ci ha avvertito, forse in un momento di resipiscenza.
Secondo Cerf, con il continuo aggiornamento dei sistemi operativi e dei software (quella roba, insomma, che ci toglie il sonno e ci fa venire le vertigini ogni volta che il messaggino che l’annuncia appare sui display dei nostri cellulari), i documenti e le immagini salvate con le tecnologie che rapidamente diventano obsolete, saranno sempre più inaccessibili.
Ecco perché in un futuro tutt’altro che lontano coloro che volgeranno lo sguardo all’indietro scopriranno il “deserto digitale” come incubo annunciato che si è materializzato.
Domanda e risposta, a questo punto, sono fin troppo ovvie. “Come preserviamo tutti i bit di cui avremo bisogno per interpretare correttamente gli oggetti che abbiamo creato? Senza neanche rendercene conto, stiamo gettando tutti i nostri dati in quello che rischia di diventare un buco nero dell’informazione”, dice Cerf.
Fino a quando, negli anni Ottanta, i documenti venivano salvati sui floppy disk, la sicurezza di trasmettere dati, foto, libri era abbastanza sicura. Adesso perfino chi conserva quei quadratini che i millennials o la generation next ignorano non sa che cosa farsene dal momento che ci siamo sbarazzati degli strumenti operativi per “aprirli”: qualcosa si trova nei musei, inservibile comunque. Come si disse che erano inservibili i vecchi dischi in vinile e tutti diedero via costosissimi e meravigliosi stereo salvo poi ricredersi perfino sulla qualità del suono. Ma dischi e giradischi si possono ancora produrre, la memoria che si porta via la nostra vita, no.
Perciò, secondo Cerf, la “putrefazione del bit” inevitabilmente ci negherà il passato. E senza passato è difficile immaginare il futuro, oltre a decifrare il presente. Perciò, il vice-presidente di Google suggerisce di conservare gelosamente una foto a cui teniamo, un testo da non dimenticare nel computer o nella pen-drive: riproduciamo tutto, evviva la carta, la stampa, l’inchiostro e pure la carta-carbone (hai visto mai che si perda l’originale).
“Nel nostro zelo – ammoniva Cerf – presi dall’entusiasmo per la digitalizzazione, convertiamo in digitale le nostre fotografie pensando che così le faremo durare più a lungo, ma in realtà potrebbe venir fuori che ci sbagliavamo. Il mio consiglio è: se ci sono foto a cui davvero tenete, createne delle copie fisiche. Stampatele”.
Per rendere ancora più chiaro il suo discorso, Cerf ha portato – senza commuovere nessuno – l’esempio di un libro su Abraham Lincoln scritto dalla storica americana, premio Pulitzer, Doris Kearns Goodwin, analista politica, biografa, tra gli altri, di Lyndon Johnson e della famiglia Kennedy, ma anche di Theodore Roosevelt, di Howard Taft e autrice di un magnifico testo sull’età dell’oro del giornalismo statunitense. Quando si è occupata di Lincoln ( “Team of rivals: the political tenuissimi of Abraham Lincoln”) ha consultato imponenti bibliografie sul mitico presidente, ma soprattutto si è servita per scrivere la sua biografia, probabilmente la migliore e la più accurata, della corrispondenza tra Lincoln e tutti coloro con cui ha avuto a che fare. Cerf ha commentato: “Immaginiamo che ci sia una Doris Kearns Goodwin del Ventiduesimo secolo che voglia scrivere un libro sull’inizio del Ventunesimo secolo cercando di avvalersi delle conversazioni di quel tempo. Scoprirebbe che enormi quantità di contenuti digitali sono o evaporati, perché nessuno li ha salvati, o a disposizione ma non interpretabili, perché creati con software vecchi di cento anni”.
Esiste una via d’uscita? Secondo Cerf potrebbe essere quella che ha definito “pergamena o manoscritto digitale”, un progetto su cui stanno lavorando gli ingegneri della Carnegie Mellon University di Pittsburgh. In sostanza si tratta di fare delle “istantanee digitali” (“snapshot”) – praticamente la realizzazione della copia nel momento in cui un oggetto viene salvato – di tutti i processi che in futuro saranno necessari per riprodurlo, incluso il software e il sistema operativo.
È un’ipotesi. Tutt’altro che convincente, almeno fino a quando non se ne saprà di più. E intanto noi stiamo qui a veder crescere il “deserto digitale”. Giorno dopo giorno la memoria affievolisce mentre nell’antichità re, faraoni, sacerdoti, profeti e cialtroni erano talmente consapevoli della sua importanza da affidare a scribi e cantastorie la narrazione di fatti e gesta, nobili ed ignobili, testimonianti comunque un cammino umano del quale siamo debitori. Almeno fino ad oggi inconsapevoli che il deserto cresce e la tecnologia tenta di riempirlo con quegli stessi strumenti digitali che uccidono i ricordi. Nel modo più orrendo: affermando l’ideologia della volgarità che, unitamente alla memoria, travolge un altro pilastro della civiltà: la riservatezza, il diritto all’intimità, il piacere di godere dell’inviolabilità dell’esistenza.
Credevamo che nelle pieghe del “privato” non ci si potesse addentrare come ladri che frugano negli anditi più riposti delle abitazioni. Invece, sperimentiamo che nessuno è al riparo dalle incursioni nella nostra vita più segreta. Sicché ciò che è privato è diventato più che pubblico, universale. E non si salva niente dall’invadenza tecnologica che brucia intimità e verità, perché con i cosiddetti “social” ogni parola, qualsiasi gesto è ritenuto “degno” di essere gettato nell’immondezzaio della spettacolarizzazione. E più è riservato l’oggetto dell’“invasione”, tanto più se ne fa strame. Dandolo in pasto a chi si nutre voluttuosamente di altre esistenze i cui tormenti evidentemente appagano tendenze inconfessabili a godere delle disgrazie altrui o degli altrui segreti. Ci si apparenta tra sconosciuti e così l’amicizia perde il valore reale e regredisce a finzione, è infatti virtuale. Dal deserto della memoria al deserto affettivo.
Il cannibalismo mediatico si serve di aggressivi strumenti adoperati immoralmente perché la “notizia” (chiamiamola così) non possa essere soggetta a nessun vaglio morale. E allora avanti con lo schiamazzo che mette in piazza il proibito, con il cinismo dell’appropriazione indebita delle libere manifestazioni private di ciascuno, con il pettegolezzo che diventa verità rivelata senza curarsi minimamente dell’impatto che ha su soggetti la cui dignità viene messa sotto i piedi da individui che vampirizzano chiunque abbia una visibilità e perfino quelli che non ce l’hanno ma possono, adeguatamente manipolati, diventare mostri da esibire. Ordinarie lacerazioni umane si producono così sotto i nostri sguardi. Il Grande Fratello è l’utopia realizzata. Purtroppo non si tratta del noto programma trash televisivo, ma un gigantesco voyeur mediatico che fruga nelle nostre vite, spia i sentimenti più riposti che vorremmo tenere soltanto per noi, si ciba delle debolezze e delle ingenuità di ciascuno, senza riguardo né per gli umili, né per i potenti. Legalmente, illegalmente? Poco importa. Incontestabile è il risultato che ottiene: intercettare sofferenze, dolori, angosce, amori, segreti, patimenti, gioie privatissime e relegare tutto in qualche armadio fino a quando verrà buono tirar fuori brandelli di vite violate. Oppure impacchettare ogni cosa e farla circolare su internet a beneficio del popolo internettiano che vive nutrendosi di ciò che fanno gli altri. Non è uno spettacolo edificante, si converrà, ma si dice anche che esso fa parte della modernità. Anche per questo, probabilmente, siamo più infelici, come scrisse qualche anno fa il “New York Times” destando proteste a destra e a manca senza che nessuno provvedesse a chiedersi il perché di una condizione umiliante, quale raramente è stata riscontrata nel nostro tempo.
La tecnologia informatica, oltre che attentare alla memoria ci rende più aridi, insensibili, oppressi, depressi, insicuri. La sua invasività è il nostro tormento. La certezza di essere spiati fa ormai parte del nostro costume e a nulla valgono le periodiche quanto inutili proteste contro un incubo da secoli bui. L’essere immersi in una sorta di invisibile inquisizione permanente, non ci scandalizza più di tanto: lo diamo per accettato, inevitabile insomma. E ci facciamo spogliare delle nostre prerogative ritenute un tempo più che inviolabili, quasi sacrali.






