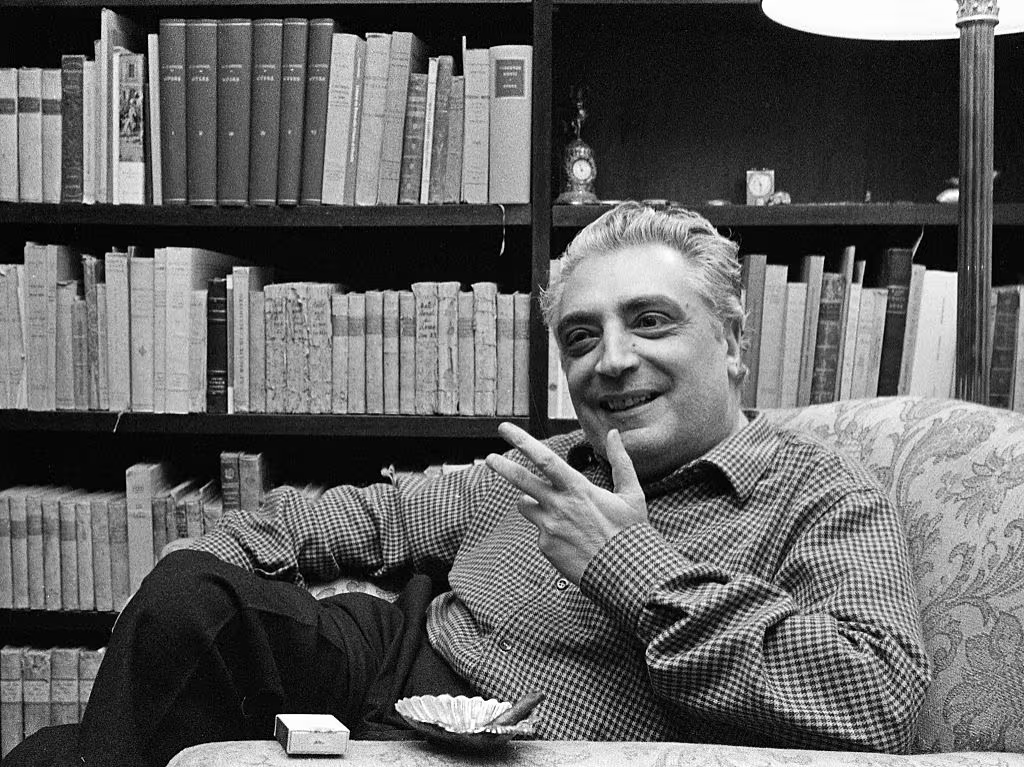Esistono dei diritti non negoziabili, attraverso i quali è possibile garantire una crescita ordinata dell’uomo e dunque della società? Dove e come individuarli? Quali conseguenze ha il relativismo etico sull’organizzazione della società? Il suo manifestarsi, radicalizzarsi e radicarsi può essere ridotto alla sfera meramente privata dell’individuo?
La nuova frontiera dei diritti è quella di “fare domande”. Dalla loro formulazione passa la verifica di quelli che possiamo definire i “costi sociali” del relativismo etico, cioè le conseguenze sociali delle analisi filosofiche, antropologiche, sociologiche, politiche che stanno alla base del relativismo.
Senza negare il valore fondante dell’annuncio religioso e della Fede, che tuttavia – come insegna la Dottrina – resta un libero atto della volontà, è possibile porre il problema del relativismo etico in rapporto con le sue ricadute sociali.
Dal livello spirituale ci si sposta su quello razionale. Dalle affermazioni di principio alla stringente verifica delle conseguenze immediate e future. Da un’idea disarticolata di libertà ad una libertà impegnata a costruire l’armonia.
La grande questione con cui il mondo moderno deve, oggi, fare i conti è quella di riuscire a coniugare i valori della persona e quelli sociali, i diritti soggettivi e quelli della società, pluralismo ed elementi fondativi del vivere comune.
Questo quadro d’assieme impone una duplice assunzione di responsabilità da parte dell’individuo nei confronti della società, da parte della società nei confronti dei suoi componenti.
Che cosa significa ? Significa innanzitutto che le semplificazioni filosofiche, figlie dell’idea che la tolleranza ed il diritto alla contingenza siano i primi diritti fondamentali, vengano meno di fronte alla complessità e alle domande di razionalità e di buon senso che emerge da una lettura non ideologica della realtà.
Ne consegue che un centro ordinatore non è in contraddizione con l’idea del pluralismo che si pone a base delle società libere. Si può anzi dire che la rinuncia, nel nome del relativismo etico, ad un’etica fondativa rappresenta un elemento di debolezza per le ragioni della coesione sociale e della piena manifestazione della libertà e dunque per la stessa tenuta del sistema democratico.
Nel segno dell’indifferentismo sociale tutto è irrazionalmente discutibile. Nella permanente discussione sulle natura dell’uomo, sui suoi diritti, viene ad indebolirsi il senso stesso dell’esistenza, con dei costi individuali e sociali altissimi, pagati dalle fasce più deboli della popolazione, quindi dalla sua maggioranza.
E’ perciò un errore credere che il “relativismo etico” sia un semplice problema intellettuale, da analizzare e da discutere all’interno dei circoli filosofici, tanto lontano dalla sensibilità collettiva da essere incomprensibile ai più, o una questione tutta religiosa, da rinchiudere nelle sacrestie e da lasciare all’attenzione del solo magistero della Chiesa.
L’argomento è certamente rivestito da un’armatura intellettuale, che sembra impedire l’esatta comprensione della sua essenza. D’altra parte esso facilita l’approccio semplificatorio, consegnandosi alla banalizzazione di massa, veicolo di una inconsapevolezza diffusa e rassicurante.
L’approccio culturale al problema si muove partendo da una considerazione molto facile e diretta: la verità come possibilità del pensiero non esiste, quindi è inutile cercarla ed ancor più informarsi ad essa. E’ una posizione filosofica che bene si sposa con lo spaesamento dell’uomo contemporaneo, offrendogli le giustificazioni intellettuali per tale spaesamento.
Su questa base non vale perciò la pena ricercare o coltivare verità assolute, quanto piuttosto prendere coscienza che ogni conoscenza è condizionata da elementi di ordine sociale, culturale e politico. Ne consegue – secondo i relativisti – che ogni verità è il prodotto della cultura ricevuta. Spezzare la catena della tradizione, intesa come trasmissione di verità, è dunque possibile e necessario – secondo tale orientamento – per realizzare una piena liberazione dell’uomo.
Le conseguenze di tale “rottura” poco interessano e ancora meno vengono valutate. Il fine è la liberazione, fine che si fa verità autosufficiente ed assoluta, contraddicendo la scelta di partenza, secondo cui la verità non esiste e non va cercata.
A questo punto però il confine tra libertà ed arbitrio assoluto diventa labile. Senza limiti morali la libertà del relativismo etico finisce per sovrastare i diritti altrui, mentre la legge diventa un fragile paravento, inadeguato a proteggere le vittime del relativismo stesso.
Pensiamo, nel campo del diritto di famiglia, alle conseguenze del divorzio nei confronti del coniuge debole e dei figli; nel caso dell’aborto ai diritti del nascituro e a quelli del padre non consenziente; nel campo della bioetica ai rischi determinati da normative che avvalorano l’eutanasia contro il soggetto malato.
La libertà del relativismo tanto più è assoluta, cioè senza limiti, tanto più appare foriera di nuovi traumi all’interno del corpo sociale.
Con questi mali occorre fare i conti. Conti morali ed insieme sociali ed economici, proprio per la capacità che essi hanno di segnare il corpo della società.
Con quali conseguenze e con quali costi ?
Viviamo in un tempo ben strano, pieno di controsensi, di contraddizioni tanto grandi quanto tenute ben nascoste al senso comune o spesso capaci di carpirne la buona fede.
Ci si preoccupa giustamente della sicurezza del cittadino e della sua salute. Gli si impongono misure atte a salvaguardarne la sicurezza motoria: caschi e cinture, controlli periodici e vincoli.
La libera vendita delle sostanze stupefacenti è proibita. Sui pacchetti delle sigarette vengono stampigliate scritte allarmanti sul rischio di morte.
Uguale zelo non sembra essere destinato ai rischi determinati dalla messa in crisi della famiglia, dall’aborto, dall’assunzione di sostanze stupefacenti e dalla messa in discussione dell’ordine naturale.
“Relativizzare” l’etica, con ciò che comporta per le sue ricadute sulla vita del singolo individuo, delle famiglie, della società, appare un diritto da allargare, un impegno quotidiano per il quale non debbono essere posti nuovi limiti e debbono essere rimossi i vecchi.
Non ci sono dunque cintura di sicurezza o caschi, né particolari avvisi per chi voglia fare del relativismo etico una sorta di laboratorio permanente delle proprie spericolatezze, laddove invece, in altri contesti, cinture, caschi, avvisi particolari vengono posti a tutela della salute dei singoli e della collettività.
Dei rischi a cui viene esposto dall’espandersi del relativismo il cittadino non viene allertato. Non ci sono cartelli indicatori che lo avvisino. Non ci sono campagne informative che lo mettano sull’avviso. Al contrario, egli è quotidianamente sottoposto ad una costante opera di indottrinamento inconsapevole, in grado di rendere dolce il processo di depotenziamento collettivo, di resa, di assuefazione. E tutto questo senza che le conseguenze concrete di tale deriva siano ben chiare a chi le farà. Senza che i costi sociali e personali siano chiaramente indicati.
Accade così che, riempito il ricco carrello del relativismo, l’ignaro cittadino arrivi alla cassa senza sapere il prezzo da pagare, convinto anzi che tutto gli è dovuto gratuitamente. Il risultato è che le conseguenze di tali scelte ricadano sul malcapitato, al punto da stravolgere la sua vita e quella di chi gli sta intorno. Proviamo a moltiplicare queste conseguenze per milioni di volte ed avremo il quadro della società moderna, scricchiolante e sempre più instabile.